Culture + Arts > Visual Arts
March 15, 2021
Cosa ci insegnano le Alpi. Design, arte, cultura 03: Stefano Cagol
Emanuele Quinz
Per il terzo episodio della nostra serie, incontriamo l’artista Stefano Cagol, artista. Nato a Trento, nel 1969, ha studiato all’Accademia di Brera e alla Ryerson University di Toronto. Ha tenuto mostre personali nel mondo intero, esponendo in istituzioni come il CCA Center for Contemporary Art Tel Aviv, museo MA*GA, Mart, CLB Berlin, ZKM Karlsruhe. Ha partecipato alla 55° Biennale di Venezia, Manifesta 11, 14° Biennale di Curitiba, 2° OFF Biennale Cairo, 2° Xinjiang Biennale, e 1° Biennale di Singapore. Le sue opere, spesso multi-formi e multi-sito, riflettono sui temi dell’oggi, dai confini, ai virus, alle questioni ecologiche e dell’interferenza dell’uomo sulla natura.
Qual è il tuo rapporto con le Alpi?
Sono la mia casa. Ho studiato a Milano e Toronto, e nei primi anni della mia carriera da artista sono stato attratto dalle metropoli, New York, Tokyo, Londra, Bruxelles, ma ho deciso di tornare sempre in Trentino. Anzi, da Trento mi sono spostato più in alto: da diciotto anni ho la residenza in un paese in Val di Non. La luce, i riflessi del lago, le Dolomiti all’orizzonte: questo è il mio punto fermo tra progetti che mi portano continuamente altrove.
Puoi raccontare una storia, un ricordo personale, una parabola, un aneddoto legato alle Alpi?
É uno dei ricordi che più hanno influenzato la mia ricerca, alla base di un’opera davvero centrale nel mio percorso.
Quando avevo cinque anni, la mia famiglia si è trasferita a Berna e sono cominciati lunghi attraversamenti delle Alpi in auto, per passare le vacanze nella casa di origine sulla collina di Trento. Attraverso i Grigioni, l’Engadina, il Vorarlberg, superando valichi alpini notevoli, come il Flüela, l’Ofenpass e l’Arlberg. Erano gli anni Settanta e le strade erano strette e difficoltose, le auto lente, ogni viaggio un’impresa. Mentre guidava, mio padre mi raccontava di quelle incredibili cime e indicava i ghiacciai candidi, pronunciando un termine che suonava magico alle mie orecchie: “Quelli sono i ghiacci eterni”, mi diceva. Nell’attimo di pochi decenni, l’eternità è svanita, o sulla via della sparizione.
Cosa ti hanno insegnato le Alpi?
A capire potenzialità, limiti e, soprattutto responsabilità. Ma il confronto è stato diretto, con la loro profonda natura, andando fuori dai sentieri battuti.
Cosa ci insegnano le Alpi?
Sono una delle espressioni naturali che più chiaramente ci fa prendere coscienza dell’idea di tempo. Imponenti, è inimmaginabile che le Alpi furono fondali marini tropicali, nel Triassico, e sono state antiche testimoni della più grave estinzione di massa mai verificatasi sulla Terra, 250 milioni di anni fa, della quale non smettono di svelare indizi importanti. Sorte dalle acque in milioni di anni, hanno la stessa età geologica dell’Himalaya, parte di un’unica estesa catena Alpino-Himalayana, mettendo in discussione anche la nostra limitata visione dei confini. Così lontani, così vicini, come in The Ice Monolith, in cui connetto simbolicamente l’arcipelago delle Lofoten a quello delle Maldive, e le Alpi. E’ l’opera che ho presentato alla Biennale di Venezia 2013.
 Come è nato il progetto The Ice Monolith?
Come è nato il progetto The Ice Monolith?
Arriva dalle Alpi e dalle mie radici, passando per il Grande Nord e arrivando fino agli oceani tropicali.
Quando ho ricevuto la telefonata dal curatore Alfredo Cramerotti (del collettivo Chamber of Public Secret) che m’invitava a partecipare al Padiglione nazionale delle Maldive – sembra incredibile – stavo oltrepassando il Circolo Polare Artico, in Norvegia, guidando in direzione nord. E’ un luogo con un magnetismo incredibile, difficile da spiegare, che non si trova altrove, né prima, né proseguendo centinaia di chilometri verso nord. Ero diretto all’estremo confine russo-norvegese, nel corso di uno dei miei principali progetti in movimento e multi-national, come possono essere definiti (il titolo era The End of the Border). Al ritorno, avvenuto per mare, mi sono apparse le isole Lofoten innevate, che ai miei occhi erano come cime delle Alpi affioranti dall’acqua, e hanno fatto immaginare un’estrema conseguenza dell’innalzamento del livello del mare, già minaccia reale per le isole maldiviane. Da qui, l’idea di utilizzare l’immagine della sparizione dei ghiacciai come metafora, simbolica ma tangibile, per porre tutti noi di fronte alla complessa questione climatica. Ora, dopo anni, quest’opera continua a far sentire il suo messaggio: mi stupisce come continui a essere popolare, pubblicata e citata. Tra tutte le analisi, una delle più interessanti è di Julie Reiss, professore associato e direttore del programma Christie’s Education a New York, che ha firmato un intenso saggio su Minding Nature nel 2019[1], mettendo a confronto tre opere realizzate con ghiaccio dei ghiacciai: una di Olafur Eliasson, una di Tavares Strachan, e The Ice Monolith, riconosciuto come estremamente incisivo.
A me ha fatto venire in mente altre due opere (concettuali) che usano il ghiaccio – Fluids di Allan Kaprow (1967), performance in cui con l’aiuto di volontari, l’artista costruisce delle strutture di mattoni di ghiaccio, che fondono rapidamente sotto il sole della California – e Ice House I e II di Gianni Pettena (1971-1972), in cui una casa è coperta dal ghiaccio. In tutti i casi, lo scioglimento del ghiaccio evoca la dimensione effimera dell’intervento umano, riassorbito dai cicli naturali.
In effetti sono opere veramente importanti. Il ghiaccio come medium nell’arte ha numerosi esempi apprezzabili, in epoche diverse, con molteplici prospettive e narrative.
Il puntuale e serio KunstBulletin svizzero mi dedicò copertina ed editoriale (a firma della direttrice Claudia Jolles)[2] del numero speciale della Biennale, proprio nell’estate 2013, particolarmente torrida. In quel caso ci fu un rimando anche alla performance di Francis Alÿs del 1997, Paradox of Praxis 1, in cui trascina un blocco di ghiaccio fino alla sua sparizione per le strade di Mexico City. L’articolo metteva in rilievo la differenza della durata delle due opere: il cubo di Alÿs ci mette nove ore a scioglersi, il mio settantadue. Luoghi, ore, pesi e intenzioni diverse.
 Altre tue due opere, Ice Melting Ice e la performance Eterno, realizzate nel 2019 a Bressanone, parlano della scomparsa dei ghiacciai. Quali sono state le reazioni del pubblico e della critica davanti a queste opere che evocano uno scenario apocalittico, e ricordano la gravità della crisi ecologica.
Altre tue due opere, Ice Melting Ice e la performance Eterno, realizzate nel 2019 a Bressanone, parlano della scomparsa dei ghiacciai. Quali sono state le reazioni del pubblico e della critica davanti a queste opere che evocano uno scenario apocalittico, e ricordano la gravità della crisi ecologica.
Il contesto era quello del Water Light Festival della città di Bressanone, che definisce tra i suoi obbiettivi una riflessione su temi urgenti legati all’acqua. Per questo, nel corso della sua terza edizione ha ospitato il Festival dell’acqua, dedicato a specialisti del settore dell’energia, dell’innovazione e delle risorse idriche. Davanti a loro ho messo in atto la performance Eterno, usando ghiaccio, fuoco, una bomboletta spray e un martello. Uno di loro ha osservato: “Di partenza ero scettico nei confronti di un intervento artistico, ma quando ho visto il ghiaccio colpito a martellate, tutto mi è stato chiaro!” Solo quando l’arte riesce a essere universale, decodificata da molti, allora può essere chiamata tale.
Anche Ice Melting Ice, una monumentale scritta al neon con un messaggio forte e chiaro, installata nel punto di confluenza di due fiumi alpini, l’Isarco e la Rienza, ha saputo raggiungere un pubblico vasto attraverso l’attenzione dei media, passando su notiziari nazionali in Italia, Austria, Germania, e andando a segno su Euronews.
Tutte queste opere, da una parte rivelano un legame profondo con il territorio delle tue origini, e dall’altra esplicitano la funzione di denuncia dell’artista. Pensi che l’arte debba essere necessariamente critica o politica?
L’artista – almeno il buon artista – deve avere un ruolo sociale, quindi anche politico, e la sua visionarietà può, anzi deve anticipare il futuro. Le modalità e la portata di questa capacità d’intervento possono essere molto diverse, ma tutte altrettanto importanti. Un esempio emblematico in questa direzione ritengo sia Joseph Beuys, che ha avuto un ruolo molto rilevante nella fondazione del partito dei Verdi in Germania negli anni Settanta.
 Ci sono altri artisti che ti hanno ispirato, per lo stesso rapporto di vicinanza con le Alpi?
Ci sono altri artisti che ti hanno ispirato, per lo stesso rapporto di vicinanza con le Alpi?
Due nomi, distanti tra loro: Richard Long e Giovanni Segantini. Con quest’ultimo, trentino come me, condivido, almeno in parte, la scelta di spostarsi a vivere lontano dalle città nel mezzo di un paesaggio dominato dalla presenza di un massiccio alpino, dove condurre una ricerca concentrata e raccolta.
Le mie spedizioni in solitaria in luoghi lontani dalla presenza antropica, soprattutto nel Grande Nord, sono, invece, state avvicinate da Jeni Fulton ai progetti in cammino sulle Alpi di un Land Artist come Richard Long.
Di Long ricordo molto bene la mostra al Mart nel 2000: precedeva immediatamente la mia, abbiamo vissuto lo stesso spazio espositivo, entrambi rientravamo nella medesima serie di esposizioni sotto il titolo “Contemporanea”, a cura di Gabriella Belli, tutte mostre eccezionali. É stato un momento focale nel mio percorso, la mia prima personale in un museo, un inizio – sotto l’auspicio delle Alpi.
[1] https://www.humansandnature.org/terra-incognita-exhibiting-ice-in-the-anthropocene-1
[2] https://www.artlog.net/de/kunstbulletin-7-8-2013/editorial
Graphic design Studio Babai
Photo (c) Stefano Cagol

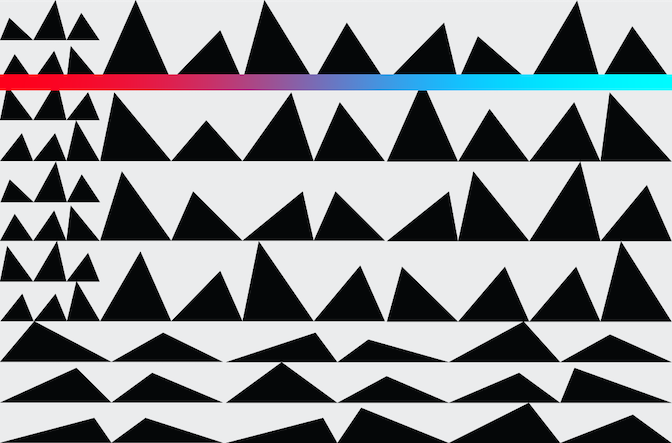
















Comments